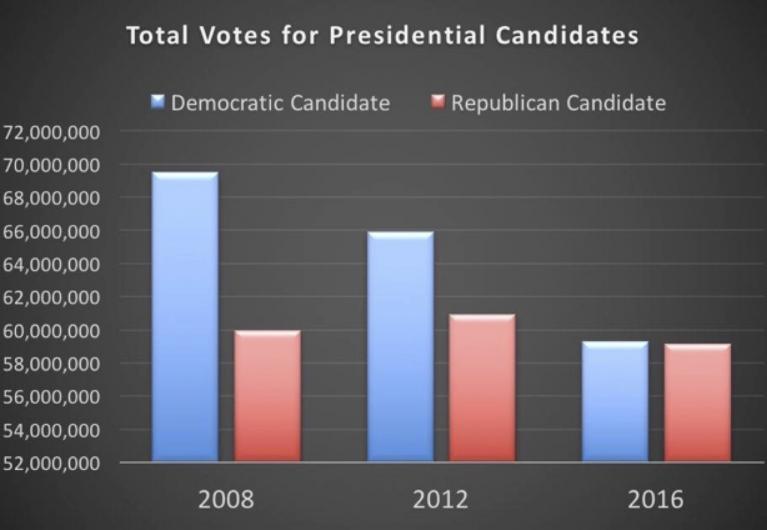
| Home | Scritti e commenti | Rosso un fiore |
martedì 15 novembre 2016
[all'alba di questo giorno, nel 1943, vennero fucilate 11
persone a Ferrara, rastrellate il giorno prima, come rappresaglia per
l'uccisione del federale Igino Ghisellini]
[Questo articolo è stato pubblicato sulla pagina web dell'Istituto Cattaneo]
Si è fatto un gran
parlare e con scarsa fantasia giornalistica si è voluto riprendere il titolo di
una graziosa raccolta di Italo Calvino che ben altri contenuti aveva. Ma è vero
che queste elezioni americane ci hanno dato più di una lezione, per quanto “orribile”
il risultato ci possa apparire. Tra le lezioni che impareremo ad apprendere ce
ne sono due che vorrei commentare.
La prima suona non più
come un campanello d’allarme ma come un vero e proprio rombo di cannone, per la
politica e le sorti della democrazia, soprattutto per chi guarda, da sinistra,
alla partecipazione come il risultato di una società matura, democratica e
pluralista: l’astensione dal voto esercitata come protesta e manifestazione
della disillusione.
Trump ha vinto ma non ha stravinto. Ha conquistato la maggioranza dei collegi elettorali – non dei voti – e grazie al meccanismo elettorale ha vinto. Ma ha vinto con margini esigui e soprattutto raccogliendo poco più voti di quanti non ne avesse raccolti il candidato repubblicano nelle scorse elezioni, contro Obama. Anche se i dati sulla partecipazione elettorale non sono ancora ufficiali, l’evidenza drammatica del voto americano è il crollo dell’affluenza al voto. Se 131,5 milioni di americani hanno espresso la loro preferenza, ben 90 milioni si sono astenuti. Hanno votato il 57.9% degli aventi diritto, laddove nel 2012 erano stati il 58.6% e nel 2008 il 61.6%. Clinton ha ottenuto circa 62,8 milioni di voti, mentre Trump ne ha avuti ben un milione e 300 mila in meno. Clinton ha vinto nelle città, Trump nei sobborghi e nelle vaste aree rurali. Guardando al voto per contee, si vede che Clinton ha vinto nelle zone abitate dal 54% della popolazione residente (174 milioni). Isole urbane in un mare di cinture industriali, pianure e zone montane.
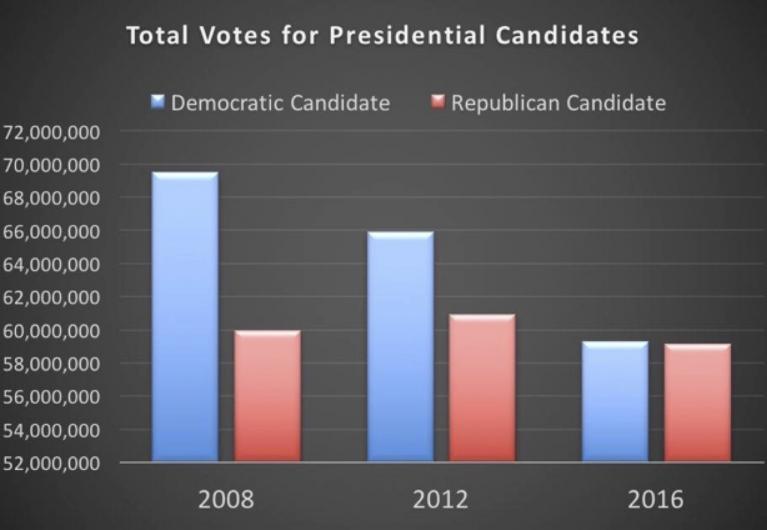
Eppure, Clinton ha perso.
I collegi elettorali si vincono con la maggioranza, e questo ha fatto Trump. La
mappa stato per stato mostra che dei 30 stati che hanno preferito Trump, 17
hanno visto un aumento della partecipazione, mentre dei 21 che hanno preferito
Clinton, ben 11 hanno visto un calo. Negli “swing states” (quelli in bilico),
Trump ha vinto con maggioranze risicate, ma ha vinto. E il consenso maggiore
per Trump è venuto proprio da quelle contee dove la maggioranza è di bianchi
non laureati, la white working class (andamento
del voto per gruppi tra il 2004 e il 2016, fonte: New Work Times).
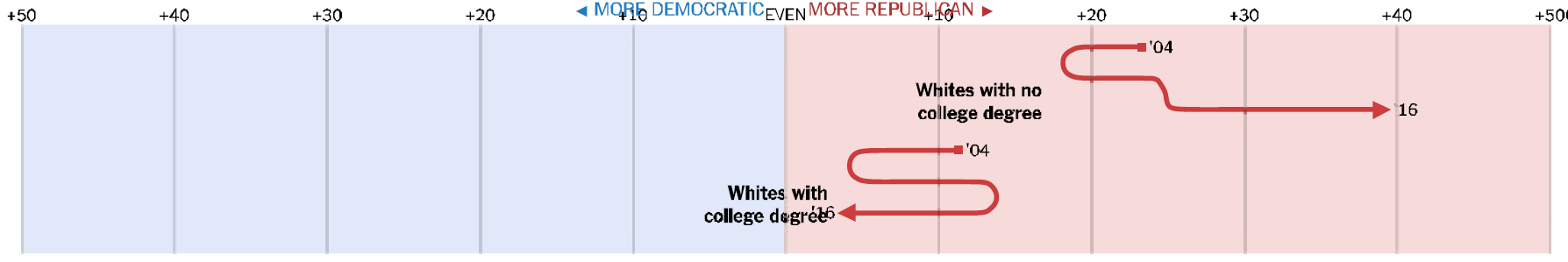
E se neri, ispanici,
asiatici e nativi hanno votato en masse
per Clinton, è pur vero che è il loro supporto che è drammaticamente calato
rispetto a quello che avevano espresso per Obama, come mostra questo grafico
(andamento del voto per gruppi tra il 2004 e il 2016, fonte: New Work Times).
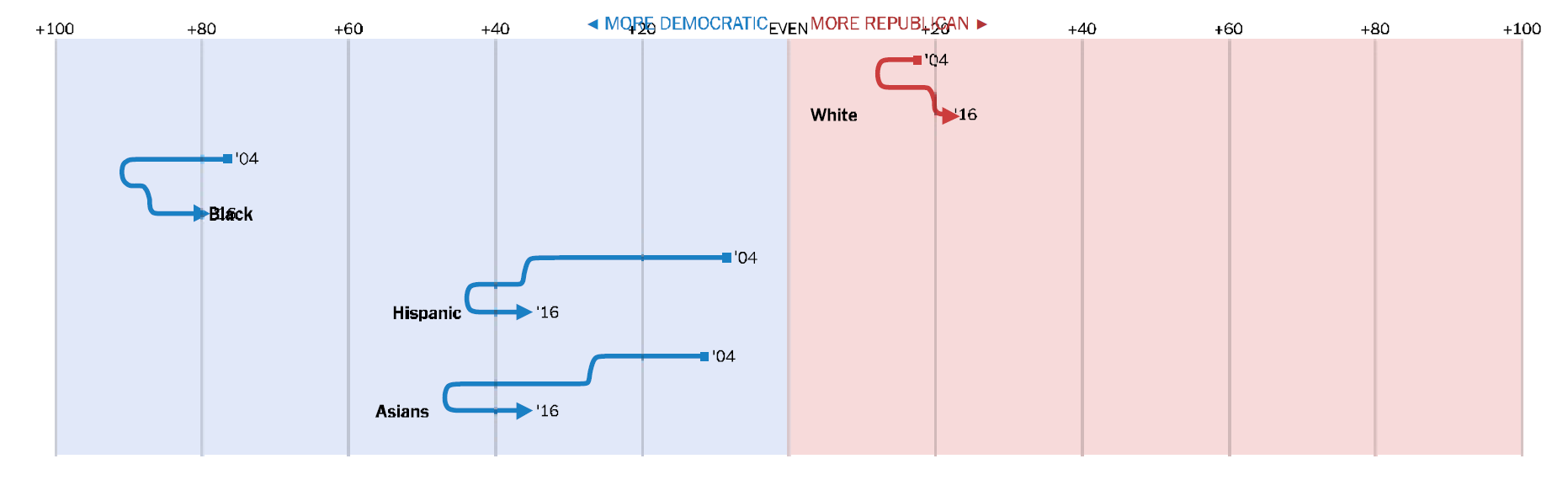
Se il tycoon palazzinaro,
uomo dei media e miliardario – proprio come il nostro ex croupier poi assurto a
presidente del consiglio più di vent’anni fa – ha catalizzato la rabbia
schiumosa della white working class delle
rust belts e delle great plains, questa ha avuto la meglio
sul voto giovanile, nero, ispanico, femminile delle grandi città dell’est e
dell’ovest, scolarizzato, informato, desideroso di avanzamento economico e sul
piano dei diritti. Il tycoon non ha stravinto, ha semplicemente vinto,
raccogliendo la maggioranza in molti stati grazie al non voto di quei ceti e
gruppi sociali che già avevano seguito con una certa speranza Obama e che
Hillary Clinton, per la sua appartenenza ad un establishment visto come
refrattario ad un cambiamento che già con Obama aveva faticato a manifestarsi,
non ha saputo riportare al voto. Non ci hanno creduto, non hanno avuto fiducia
e hanno lasciato il campo ai nostalgici della dominazione bianca, dello status
quo degli anni che furono. Il non voto di ceti frustrati e disillusi ha dato spazio
a quelli che non avevano più avuto voce.
È impressionante
soprattutto come il voto giovanile, di giovani bianchi neri e ispanici, con
titolo di studio sia calato drasticamente, a fronte di un voto di bianchi,
uomini, senza titolo di studio, che è invece cresciuto come mai prima. Il 70
per cento di quelli che hanno votato per il tycoon – secondo un’indagine svolta
a caldo – avrebbe dichiarato che “si stava meglio negli anni ‘50” e che quella
è stata l’età dell’oro. Quote di giovani che avevano votato per più del 40% per
Obama sono scesi sotto il 10%... Certo, la white
working class è divenuta maggioritaria. Ma questo è potuto accadere perché
la working class composta di neri,
ispanici e asiatici, di laureati e white collars è venuta meno, disillusa e
nauseata. Il messaggio razzista, misogino, bigotto e revanscista ha avuto la
meglio su un messaggio “progressista” ormai svuotato. Hanno detto no in tanti,
non sono andati a votare, e così hanno prevalso gli altri. L’America di oggi
non è più razzista e misogina di ieri. Ma è un’America dove i giovani, le
minoranze, gli immigrati hanno perso fiducia.
Nel 2008, Obama- con la
sua travolgente campagna all’insegna del “yes, we can” – aveva ricevuto ben
69,5 milioni di voti, contro i 60 milioni del suo opponente McCain. Ben 8
milioni di votanti democratici non si sono ripresentati all’appello, laddove
Trump ne ha ricevuti appena 600 mila in più di Romney. Sono quegli 8 milioni di
delusi quelli sui quali ci si deve interrogare oggi. Se c’è da capire cosa è
riuscito a promettere il tycoon a quella “maggioranza” che era rimasta
silenziosa per decenni, sovrastata da una maggioranza che soprattutto con Obama
aveva ritrovato fiducia, è anche vero che c’è da capire perché il messaggio
progressista non è passato.
Se non è irrealistico
pensare che quelli della white working
class saranno i primi a non beneficiare delle eventuali politiche che ne
verranno – forse che i repubblicani del congresso si appresteranno a mettere in
atto politiche a favore di quei ceti medio-bassi? Ma chi ci crede? – c’è
soprattutto da capire che il vero allarme viene dall’astensione di giovani,
neri, ispanici, immigrati, musulmani e di ogni altra fede, gente che non vede
più nelle politiche dell’establishment la risposta ai loro bisogni e che,
forse, solo Bernie Sanders era riuscito parzialmente ad intercettare. Il tycoon
non ha vinto di molto ma ha portato a sé una maggioranza retrograda, facendo
leva sul razzismo, il desiderio di rivalsa, anti-urbano, anti-culturale,
bigotto, anti-storico perfino, del ventre cupo della provincia americana.
Clinton, invece, non è riuscita a portare al voto quelli che avevano creduto
nelle politiche che non sono venute, che Obama non è riuscito a rendere, quel
ceto urbano misto, quelle minoranze che hanno sempre guardato all’America come land of opportunity e che oggi si
ritrovano penalizzate da un sistema che le stritola, disilluse.
La seconda lezione – già messa in luce dal referendum inglese sulla Brexit – è che il tema della re-distribuzione, delle diseguaglianze crescenti è divenuto caldissimo e gli esiti del malcontento da questo generati sono evidenti nel consenso che sempre più gli appelli contro una globalizzazione e un primato dell’economia e della legge del capitalismo selvaggio che annienta raccolgono. Se guardiamo a ciò che il trumpismo adombra, troviamo in esso un mix micidiale: contro il libero scambio, contro l’immigrazione, contro il mix culturale, il richiamo ad uno status quo perduto a causa delle forze oscure del mercato, dell’economia che favorisce l’1% contro il 99% che ne è escluso. Non è stata certo la Clinton a raccogliere le forze vive di fasce che aspirano ad un’economia più giusta, che premi il talento quanto il reddito, che difenda i deboli e gli esclusi, che dia ai più sottraendo ai pochi.
Laddove il voto
democratico ha prevalso, il reddito medio è più alto, il che vuol dire due
cose: che le classi medie o basse o hanno votato per Trump (la white working class) o non sono andate a
votare (neri, immigrati, giovani). Chi ha votato per il tycoon vuole ritornare
al prima, è vero, è un mix fatto di
esclusi, emarginati, senza speranza – lavoratori o ex-lavoratori dei settori
“tradizionali” – tanto quanto come chi aveva sperato in Occupy Wall Street o in
politiche redistributive e non è tornato a votare. Con la differenza che tra
tutti gli esclusi hanno prevalso i più rabbiosi, quelli che credono in una
mitica America che non sarà più, mentre quelli che studiano, che vedono le
opportunità di un mondo interconnesso e che vorrebbero un’economia più giusta
hanno detto no. Non sarà un’economia più giusta, quella che il trumpismo
porterà, non sarà certo la re-distribuzione in cima alle priorità. Tra muri
metaforici e reali, avremo un mondo in cui ci sarà meno per tutti, per
l’insipienza di una classe dirigente che non ha saputo liberarsi del mantra
liberistico dello scambio ineguale e della distribuzione iniqua.
